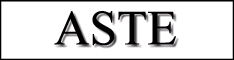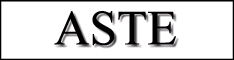|
Tribunale
di Catania, 19 dicembre 2003, Rel. Dott. Mariano Sciacca,
Reclamo - art. 700 - revoca amministratore s.n.c. - giusta
causa - esclusione socio - rapporto revoca amm. e esclusione
- nomina amministratore giudiziario
TRIBUNALE
DI CATANIA
QUARTA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1)
Dott. G. Macrì Presidente
2)
Dott. Roberta Crucitti Giudice
3)
Dott. Mariano Sciacca Giudice rel.
*
* *
Con
atto depositato in cancelleria in data 25.11.2003 Pietro La
Mela ha proposto reclamo avverso l’ordinanza cautelare
pronunziata dal Giudice Designato in data 10.11.2003.
Segnatamente
l’odierna reclamante ripropone, in primo luogo, l’eccezione
di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in considerazione
della previsione statutaria di una clausola compromissoria
di arbitrato tra i soci.
In
secondo luogo, nel merito, deduce, sotto il profilo del fumus
boni iuris, l’erronea valutazione operata dal giudice
designato in ordine all’esistenza di una giusta causa
di revoca dell’amministratore della s.n.c., tanto sotto
il profilo dell’inesistenza degli addebiti relativi alla
tenuta di una doppia contabilità dell’impresa
funzionale all’indebita appropriazione degli utili conseguiti
quanto sotto il distinto profilo comunque della mancanza di
gravità e di attualità dei fatti dedotti, ove
ritenuti esistenti.
In
subordine lamenta l’incompletezza del provvedimento impugnato,
in quanto, nel disporre la revoca dell’amministratore
della s.n.c., avrebbe omesso di nominare un amministratore
giudiziario della società medesima, eventualmente sulla
scorta delle indicazioni normative desumibili dall’art.
2409 c.c., debitamente considerando, da un lato, che statutariamente
il potere gestorio è affidato all’amministratore
revocato e conseguentemente non può essere nominato
l’altro unico socio rimasto e, dall’altro, che lo
stato attuale dei rapporti tra gli unici due soci sarebbe
ormai così deteriorato da escludersi la sola possibilità
di una nomina congiunta di un amministratore estraneo alla
compagine sociale.
Notificato
il reclamo, si è costituita Vincenza Farinato, deducendo
l’infondatezza del reclamo, nonché proponendo
in via incidentale reclamo al provvedimento di prima istanza
sotto un triplice profilo.
In
primo luogo chiede la Farinato voglia il Tribunale inibire
la facoltà di amministrazione del socio La Mela, attribuendole,
quale altro socio della s.n.c., in via esclusiva il potere
gestorio.
In
secondo luogo censura il provvedimento reso in prima istanza
nella parte in cui ha rigettato, dichiarandola inammissibile,
la richiesta di sequestro giudiziario dell’azienda per
difetto di strumentalità della domanda rispetto all’azione
di merito proponenda.
Infine
ripropone la domanda di esclusione in via d’urgenza del
La Mela dalla società, rigettata dal giudice di prime
cure sotto il profilo dell’insussitenza del fumus boni
iuris.
All’udienza
del 12.12.2003, le parti sono comparse innanzi al Collegio,
il quale, all’esito, ha riservato ordinanza con termini
per note e repliche.
IN
DIRITTO
1)
RECLAMO IN VIA PRINCIPALE.
Difetto
di giurisdizione.
Il
motivo di reclamo non ha pregio, dovendo confermare e ribadire
il Collegio, così come già avvenuto in numerose
analoghe pronunzie di questo Tribunale e della stessa Corte
d’Appello (Corte d’Appello di Catania Sent. n. 683
dei dì 19/7/2000-21/10/2000), la soluzione affermativa
della giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria relativamente all’oggetto della presente controversia.
Mette
conto a tal uopo richiamare la clausola compromissoria invocata
dal reclamante contenuta nell'art. 11 dello statuto sociale
della F.lli La Mela s.n.c. (in atti), secondo cui " qualunque
controversia tra i soci circa l’interpretazione e la
esecuzione di questo contratto sara’ rimessa al giudizio
di tre arbitri amichevoli compositori …. ".
A
tal riguardo ritiene di non potere né dovere aggiungere
nulla di più rispetto a quanto puntualmente ed esaustivamente
rilevato dal giudice di prima istanza, esclusivamente dovendosi
ribadire:
-
che la legge ( cfr. art. 806 C.p.C. e 1966 C.C.), impedisce
la compromettibilita' in arbitri delle liti tra privati, -
oltre, che per alcune ipotesi tipiche specificamente individuate,
quali le controversie di lavoro, questioni di stato, separazione
tra coniugi, - di tutte quelle controversie che non possono
formare oggetto di transazione, e cioe' di tutte quelle controversie
che hanno ad oggetto diritti che, per la loro natura o per
espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita'
delle parti ( cfr. art. 1966, secondo comma, C.C.);
-
che conseguentemente, al fine di stabilire la compromettibilita'
o meno di una determinata controversia, l'interprete e' chiamato
a stabilire se si e' in presenza di un diritto disponibile,
e cioe' tutelato dall'ordinamento con una norma dispositiva,
in funzione del potere di autodeterminazione del privato,
ovvero se si e' in presenza di un diritto indisponibile, e
cioe' di un diritto protetto con norma imperativa, in vista
della tutela di un interesse superiore e pubblico;
-
che, a tal riguardo, considerando i principi generali della
materia societaria, per verificare la compromettibilita' in
arbitri o meno di una determinata controversia occorre accertare
se le questioni da decidere coinvolgano interessi individuali
dei singoli soci, ovvero coinvolgano interessi pubblici o
di terzi, immediatamente e direttamente tutelati dalla legge;
-
che, quanto all'azione di revoca per giusta causa dell’amministratore
di una societa' di persone, promossa dal socio in vista dell'affermazione
del proprio diritto alla corretta gestione sociale ed all'utile
sociale, com'e' nel caso in esame, occorre valutare ricorra
o meno un interesse pubblico o di terzi, tutelato direttamente
dalla legge e, come tale, ostativo alla compromettibilita',
ovvero se sia configurabile un interesse privato, come tale
disponibile e compromettibile.
A
tla proposito l'esame della disciplina positiva dettata dal
codice civile con riferimento agli obblighi di rendiconto
gravanti sugli amministratori di una s.n.c., al capitale sociale
della s.n.c. e, piu’ in generale, alle regole di formazione
dei rendiconti nelle societa’ personali porta ad escludere
la compromettibilita’ in arbitri delle controversie in
tema di revoca dell'amministratore di s.n.c. per giusta causa,
laddove l’azione si fondi sulla lamentata violazione
delle regole dettate in tema di rendiconto e di quelle che
prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonche’
l’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione
sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela
di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e percio’
non deferibili al giudizio degli arbitri ( cfr. Cass. 88/1739
). Conclusione questa, così come ha rilevato il primo
giudice, avvalorata dalle considerazioni:
-
che il rendiconto previsto nelle societa' personali dagli
artt. 2261 e 2262 C.C., - espressamente applicabili alla s.n.c.
in virtu' del richiamo di cui all'art. 2293 C.C., - seppure
non e' assoggettato a forme di pubblicita' legali, a differenza
dei bilanci delle societa' di capitali, e' uno strumento di
informazione e di controllo della gestione destinato ad esplicare
i suoi effetti sia nei rapporti interni tra i soci, sia anche
nei confronti dei terzi, i quali, pur potendo contare sulla
responsabilita' patrimoniale illimitata dei soci, anche se
non amministratori, inderogabilmente prevista dall'art. 2291
C.C.., hanno un interesse giuridicamente rilevante alla veridicita’
del rendiconto, data la regola di cui all’art. 2304 C.C.
secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il
pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del
patrimonio sociale;
-
che tanto la giurisprudenza del S.C. secondo cui il rendiconto
nelle societa' personali va redatto secondo i criteri stabiliti
per le societa' di capitali, analogicamente applicabili, (
cfr. in tal senso gia' Cass. n.187/1965; Cass. 1117/68; e
piu' recentemente Cass. 4454/95; Cass. 1240/96 ) quanto la
circostanza che i rendiconti vanno di norma allegati alla
dichiarazione dei redditti presentata all’amministrazione
Finanziaria dello Stato inducono a ritenere sussistente un’interesse
pubblico sotteso alla osservanza dei principi di chiarezza
e di verita’ dei bilanci in funzione dell’accertamento
dei redditi imponibili.
Ciò
senza omettere di richiamare l'esistenza della tutela penale
prevista dall'art. 2621 n. 2 C.C., ( sicuramente applicabile
anche all'amministratore della s.n.c.), la quale costituisce
norma confermativa della rilevanza pubblicistica degli interessi
sottesi alla materia in esame.
Revoca
dell’amministratore della s.n.c. La Mela – Farinato.
Deduce
poi l’odierno reclamante in via principale, nel merito
sotto il profilo del fumus boni iuris, l’erronea valutazione
del giudice designato in ordine all’esistenza di una
giusta causa di revoca dell’amministratore della s.n.c..
Segnatamente il g.d. avrebbe errato nel ritenere sufficientemente
provata la circostanza che il La Mela abbia tenuto una doppia
contabilità, abbia gestito incassi in nero ed abbia
versato sul proprio conto gli incassi della Società.
Il
motivo di reclamo non merita accoglimento.
Ed
invero sulla scorta della documentazione in atti non può
seriamente dubitarsi che tutte le annotazioni a mano vergate
sulla cd. agenda in nero prodotta in fotocopia indichino una
serie rilevante di incassi non registrati dall’amministratore
La Mela alla contabilità ufficiale e dallo stesso sottratti
alla conoscenza dell’altro socio e versati su proprio
conto bancario.
A
tal uopo mette conto rilevare, in primo luogo, come non v’è
dubbio che gli incassi risultanti dalle copie fotostatiche
dell’agenza tenuta dal La Mela contenessero l’indicazione
di incassi non trascritti nella contabilità ufficiale
dell’azienda (v. le chiare dichiarazioni dei testi informatori
rese dinanzi al g.d. e il raffronto co n i mastrini ufficiali),
laddove poi circostanza del tutto distinta e - ai fini in
esame - fuorviante è quella che “i nominativi
segnati nell’agenda corrispondono a clienti con i quali
la società ha avuto rapporti pienamente contabilizzati”.
Ciò in quanto, la circostanza che i nominativi di clienti
in essa indicati risultassero pure nella contabilità
ufficiale nulla toglie al fatto che quegli incassi in essa
indicati non furono comunque inseriti nella contabilità
ufficiale dell’impresa, chè anzi avvalora ulteriormente
e conclama la pratica della contabilizzazione in nero di una
parte delle transazioni commerciali con una parte della clientela
(v. in tal senso i pertinenti rilievi della difesa Farinato
in note a verbale di udienza del 13.10.2003).
Quanto
poi alla ritenuta mancata dimostrazione che siasi trattato
di incassi in nero, la stessa risulta essere del tutto apodittica
e generica a fronte, per come su rilevato, debitamente considerando
le surrichiamate dichiarazione rese dai testi informatori
(testi Spataro e La Mela Piera) e la documentazione contabile
in atti, ampiamente esaminata dalle parti e dallo stesso g.d.
nella parte in cui denunzia una evidente discrasia tra la
contabilità ufficiale e quella parallelamente tenuta
dall’amministratore La Mela (v. la documentazione relativa
ai clienti Stissi e coop. Sferro, Prezzavento e Furnò,
questa anzi relativa ad un’operazione in nero effettuata
cautelare pendente, nonché la dichiarazione –
generica e razionalmente pco intelligibile nella parte in
cui tenta di giustificare la funzione delle annotazioni sull’agenda
- di Agatina La Mela, ).
Né
poi è a dire che le predette circostanze non possano
rilevare ai fni disciplinati dall’art. 2259 c.c. siccome
privi del requisito della gravità e dell’attualità.
Quanto
al primo profilo, in punto di diritto, mette conto rilevare
come parte reclamante, richiamandosi alla distinta disciplina
prevista dall’art. 2409 c.c. per le società di
capitali, introduca un elemento della fattispecie giuridica
non contemplato e richiesto dalla normativa sulla revoca dell’amministratore
nelle società di persone, atteso che il concetto di
giusta causa rilevante, ai sensi dell'art. 2259 c.c., per
la revoca di un amministratore di societa' di persone ricomprende,
da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che
compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed
il suo funzionamento; dall'altro, le condotte che, violando
obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri
dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione
della societa' e la tutela degli interessi privati dei soci
della stessa e dei terzi (in termini Tribunale Vallo Lucania,
14 ottobre 1996).
A
tal uopo significativamente alla giusta causa, quale fattispecie
costitutiva di un potere risolutivo nei rapporti fiduciari
di durata, si è dalla dottrina più avvertita
assegnata la funzione di rendere giuridicamente rilevanti
non solo gli inadempimenti a specifici obblighi assunti, ma
anche ulteriori comportamenti i quali, pur non qualificabili
come inadempimento in senso stretto eventualmente connotato
dall’ulteriore requisito della gravità (di contro
richiamato espressamente dall’art .2286 c.c. a mò
di aggettivazione connotante l’inadempimento legittimante
l’esclusione del socio), incidono comunque per la loro
significatività e gravità sul rapporto fiduciario
rendendone intollerabile la prosecuzione dello stesso.
Esemplificativamente
la nozione di giusta causa che è stata nel tempo elaborata
dalla giurisprudenza ha permesso di fare riferimento esemplificativamente:
-
alla violazione da parte del socio accomandatario dell’obbligo
di regolare tenuta della documentazione contabile e dell’obbligo
di informazione annuale (Tribunale Roma 9.10.1987, Tribunale
Milano 16.4.1984);
-
al tentativo dell’amministratore di provocare artificiosamente
lo scioglimento della società (Pretura Monza 15.6.1984);
-
al’esistenza di ammanchi dalle case sociali (Tribunale
Catania 19.10.1987) ovvero di comportamenti del socio amministratore
che si concretino nell’appropriazione di utili sociali
(Tribunale Bari 13.7.1976).
Ma,
venendo alla valutazione in concreto dell’addebito, va
rilevato, in prima istanza, che certamente grave in sé
e per sé sia il comportamento dell’amministratore,
soprattutto se statutariamente unico soggetto investito del
potere di amministrazione, come nel caso di specie, che crei
una contabilità parallela, gestendola con evidenti
fini distrattivi e di indebita appropriazione. Ciò
senza poi omettere di rilevare che, quand’anche si dovesse
reputare, così come indica il reclamante che il totale
degli incassi eventualmente sottratti alla contabilità
ufficiale dell’impresa e all’altro socio sia pari
a sole € 49.050,68, anche in tale ipotesi ricorrerebbe
un comportamento di estrema gravità, doverosamente
soggetto alla misura della revoca (e ciò indipendentemente
da ogni eventuale, ipotetica sottrazione dal totale degli
incassi in nero delle relative spese).
Quanto,
poi, all’altro profilo relativo alla mancanza di attualità
delle irregolarità evidenziate dal g.d., rileva il
Collegio, come si tenti di introdurre un elemento ovvero un
requisito ulteriore connotate la fattispecie risolutiva del
rapporto fiduciario che non ha ragione di essere, non essendo
stato mai indicato espressamente dal legislatore, né
lo stesso risultando funzionale alle esigenze sottese all’istituto
in esame, al più potendo il difetto di attualità
delle irregolarità rilevare sotto il distinto ordine
di questioni che pone il periculum in mora nella vicenda in
esame.
Né,
infine, riveste alcun pregio, né merita specifica replica
la finale deduzione relativa al diritto del reclamante a procedere
alla compensazione delle somme eventualmente trattenute in
nero con le somme dovutegli dalla Farinato.
Nomina
di amministratore giudiziario.
Lamenta,
in subordine, il reclamante La Mela l’incompletezza del
provvedimento impugnato in quanto, nel disporre la revoca
dell’amministratore della s.n.c., avrebbe omesso di nominare
un amministratore giudiziario della società medesima,
eventualmente sulla scorta delle indicazioni normative desumibili
dall’art. 2409 c.c., debitamente considerando, da un
lato, che statutariamente il potere gestorio è affidato
all’amministratore revocato e conseguentemente non può
essere nominato l’altro unico socio rimasto e, dall’altro,
che lo stato attuale dei rapporti tra gli unici due soci sarebbe
ormai così deteriorato da escludersi la sola possibilità
di una nomina congiunta di un amministratore estraneo alla
compagine sociale.
Il
motivo non ha pregio.
In
punto di diritto rileva il Collegio come la questione della
rilevanza dell’interesse dei soci alla prosecuzione del
rapporto sociale pur in presenza di contrasti endosocietari
gravi e tali da avere necessitato la revoca dell’amministratore
in carica per giusta causa impegni, e da non poco tempo, tanto
la dottrina che la giurisprudenza di merito e di legittimità.
A
tal uopo, se è - come questo Collegio ritiene –
peculiare funzione della normativa sulla revoca dell’amministratore
per giusta causa nelle società di persone quella di
potersi tutelare contemporaneamente l’interesse alla
vita della società e alla sua corretta amministrazione
(v. a tal riguardo significativamente la non recente Cass.
civ. n. 879 del 10.3.1975 in ordine al non assorbimento della
domanda di revoca dell’amministratore per giusta causa
nella distinta domanda di scioglimento della società),
giuoco forza devesi poi ritenere che l’interesse alla
conservazione della società e al proseguimento della
sua attività d’impresa deve trovare comunque un’adeguata
e consequenziale risposta dall’ordinamento giuridico
allorquando si abbia a verificare un vuoto gestorio nell’amministrazione
della società in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale
di revoca per giusta causa dell’amministratore.
Il
punto di partenza, allora, di tale ragionamento non potrà
essere che quello di valutare se mediatamente il legislatore
- in via generale e astratta - ovvero direttamente le parti
della singola società abbiano o meno rispettivamente,
approntato una regola che permetta l’adozione di un rimedio
alternativo al vuoto amministrativo creatosi.
A
tal uopo va osservato come in uno dei pochi precedenti in
materia la Suprema Corte (sentenza n. 1113 del 1963), sul
presupposto inespresso dell’assenza di una disciplina
specifica in materia, ha optato per l’applicazione analogica
dell’art. 1105 c.c. previsto in materia di condominio.
Soluzione
questa che, pur se espressamente prescelta da numerose pronunce
dei giudici di merito, non risulta - a parere del Collegio
– condivisibile, considerando come difetta nel caso di
specie uno dei due presupposti fondamentali del criterio analogico,
cioè la similitudine di situazioni a fronte delle quali
rendere operante la eadem ratio. Segnatamente nell’un
caso rileva l’esistenza di una società commerciale
e nell’altro una mera comunione di godimento. Insussistenza
della possibilità di paragone, non medesimezza o assimilabilità
delle due situazioni che è stata variamente e condivisibilmente
spiegata con riferimento o alle differenze strutturali e funzionali
che distinguerebbero la comunione dalla società (Tribunale
Ascoli Piceno 20.2.1985, Tribunale Roma 5.3.1982), ovvero
alla impossibilità che si verifichi nella società
di persone una scissione tra potere rappresentivo e gestorio
e responsabilità (Pretura Mirandola 20.2.1985), ovvero
ancora considerando la natura eccezionale della norma attributiva
al giudice del potere di intervenire sull’amministrazione
della comunione, potere di contro escluso nelle società
di persone (Pretura Milano 23.3.1981, Pretura Milano 19.2.1979).
Ciò senza omettere di rilevare come il succitato arresto
giurisprudenziale risulta essere stato poi smentito dalla
successiva giurisprudenza di legittimità, la quale
ha escluso l’applicabilità analogica dell’art.
1105 c.c.c poiché “ove nelle società personali
si verifichino i presupposti di applicabilità della
norma (consistente in una impossibilità di gestione
del patrimonio sociale per discordia tra i soci o per altra
causa) …. Tornano applicabili le norme relative allo
scioglimento del vincolo sociale” (Cass. civ. 13.1.1987
n. 134).
Secondo
altri il vuoto normativo (che tale sarebbe e non una precisa
scelta legislativa di escludere ogni intervento “gestorio
e pretorio” dell’autorità giudiziaria ordinaria)
richiederebbe di procedere all’applicazione analogica
dell’art. 2409 c.c. ovvero, quo minus, di alcune parti
della detta disposizione le quali risultino compatibili con
la disciplina della società di persone.
Soluzione
questa che, condivisibilmente ha incontrato l’opposizione
della dottrina più avvertita e della giurisprudenza,
debitamente considerandosi le plurime obiezioni cui la stessa
si espone:
-
la collocazione sistemativa dell’art. 2409 c.c. (capo
V del titolo V del libro V del codice civile) dimostrerebbe
che l’istituto è stato voluto dal legislatore
per le sole società di capitali tramite un sistema
articolato di rinvi e richiami (artt. 2488 e 2464 c.c.) (Tribunale
Napoli 24.1.1990, Pretura Milano 23.3.1981);
-
la natura eccezionale della procedura e dei poteri previsti
dall’art. 2409 c.c. che impedirebbe il ricorso all’analogia
(Tribunale Napoli 17.6.1992, con motivazione, per il vero,
non condivisibile, essendo nell’ambito delle società
di capitali l’istituto un rimedio tipico e generale predisposto
e voluto come novità rilevante dal legislatore del
1942);
-
la diversità di interessi tutelati dall’art. 2409
c.c., norma posta a tutela dell’interesse pubblico alla
corretta gestione dell’impresa; interesse questo che
non rileverebbe nel diverso ambito categoriale delle società
di persone (Tribunale Napoli 17.6.1992);
-
essere la tutela dei terzi nelle società di persone
affidata, piuttosto che all’attivazione di meccanismi
di controllo e intervento giurisdizionali, al regime della
responsabilità illimitata e solidale dei soci quale
garanzia sufficiente per i terzi e i creditori (Tribunale.
Lecce29.11.1989);
-
la concezione contrattualistica imporrebbe l’esclusione
della nomina di un soggetto esterno, estraneo alla compagine
sociale per il principio inderogabile che, nelle società
di persone, lega il potere gestorio alla responsabilità
illimitata e solidale (Tribunale Ascoli Piceno 5.7.1986).
Per
il vero, ad avviso del Collegio, le rassegnate obiezioni,
al di là della conducenza e condivisibilità
di ciascuna di esse (alcune delle quali invero sono state
convincentemente criticate), manifestano comunque una incompatibilità
complessiva - tanto sotto il profilo sistematico, che strutturale
e funzionale - del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c.
rispetto alle società di persone: la stessa espressa
previsione di siffatto rimedio nel solo ambito delle società
di capitali a fronte del silenzio serbato dall’art. 2259
c.c. in materia di società di persone non può
essere letto nei meri termini di un ingiustificabile vuoto
normativo frutto di disattenzione, ma una precisa scelta di
politica legislativa perseguita nella consapevolezza della
diversità di esigenze e di problemi che caratterizzano
le due realtà in esame.
Peraltro
non sembra possa essere priva di significato la circostanza
che l’art. 2091 c.c., con norma di contenuto e significato
indubbiamente speciale rispetto al complessivo impianto codicistico,
prevedesse la possibilità di nomina dell’amministratore
giudiziario per la sola ipotesi della violazione da parte
dell’imprenditore degli obblighi imposti dall’ordinamento
corporativo nell’interesse della produzione.
Richiamando
allora quanto inizialmente rilevato occorre interrogarsi se
il coordinamento tra il regime legale dell’amministrazione
della società in nome collettivo e le eventuali pattuizioni
intervenute tra i soci possano in altro modo concorrere a
risolvere la situazione di impasse su rassegnata.
A
tal uopo mette conto rilevare come in materia di amministrazione
e rappresentanza nelle società di persone la spettanza
del potere gestorio è di pertinenza, in difetto di
contraria pattuizione, di ciascun socio conformemente alla
disciplina prevista per la società semplice (ex plurimis
v. Cass. 6419\84); disciplina avente natura dispositiva e
come tale derogabile dai soci che ben possono attribuire il
potere di amministrazione ad un unico socio, ipotesi che si
è appunto verificata nel caso di specie ove l’atto
costitutivo prevedeva espressamente l’attribuzione del
potere gestorio al solo socio La Mela.
Previsione
statutaria derogatrice della disciplina legale dispositiva
che fintanto potrà operare a regime sino a quando non
intervenga una qualche causa di inefficacia o impossibilità
giuridica di operatività della stessa, come nel caso
che ci occupa. Segnatamente, ad avviso del collegio, il provvedimento
costitutivo con il quale si revoca ai sensi dell’art.
2259 c.c. l’amministratore unico di una s.n.c. con due
soli soci porta seco automaticamente l’inefficacia della
clausola statutaria attributiva del potere gestorio al socio
amministratore revocato, sì da dovere operare nuovamente
il regime legale previsto dal legislatore di amministrazione
disgiuntiva (Tribunale Genova 13.11.1959, seppure con riferimento
ad un caso di opzione originaria dei soci per l’amministrazione
disgiuntiva, Tribunale Roma 5.3.1982, Tribunale Reggio Emilia
17.11.1983, nonché Cass. cit. n. 134\87, la quale espressamente
prevede che “in caso di recesso o di revoca dell’amministratore
unico ciascuno degli altri soci, ove non sia pattuito diversamente,
potrà disgiuntamente esercitare i compiti di amministratore
che ineriscono al suo status (di socio con responsabilità
illimitata) “. Né è a dire che in tal modo
l’interpretazione proposta e la soluzione conseguentemente
prospettata inducano ad un surrettizio e inammissibile mutamento
del contratto sociale, atteso che la situazione che si delinea
a seguito della revoca giudiziale dell’amministratore
pone all’interprete la questione della sopravvenuta impossibilità
di operare di una singola clausola contrattuale la quale,
in virtù di un’interpretazione conservativa e
sistematicamente supportata dai dati normativi su indicati,
viene posta in una condizione di inefficacia, permettendo
ugualmente alla società di operare per il conseguimento
del suo oggetto sociale. Peraltro non sembra sia senza significato
che proprio per la revoca dell’amministratore nominato
nel contratto sociale si richieda l’unanimità
dei consensi in ossequio all’art. 2252 c.c. con eccettuazione
del consenso dell’amministratore revocato.
La
prospettata soluzione è stata, peraltro, oggetto della
critiche dottrinali che ne hanno denunciato la parzialità
e non esaustività per l’intero novero delle società
personali, al più essa potendosi adeguare all’ipotesi
di revoca giudiziale dell’amministratore di s.n.c., laddove
non potrebbe la stessa certo rilevare per il diverso caso
di società in accomandita semplice: nel qual caso l’esistenza
di una distinte categorie di soci e il conseguente riconoscimento
del potere di amministrazione al solo socio accomandatario
non permetterebbe di adottare analoga soluzione.
A
tal uopo, non investendo tale questione l’oggetto del
presente reclamo, rileva il Collegio esclusivamente per completezza
di argomentare, come siano ormai acquisiti in dottrina elaborazioni
dottrinali le quali, senza indulgere in prospettazioni analogiche
di dubbia consistenza, hanno anche in tali ipotesi, rinvenuto
proprio all’interno della disciplina della s.a.s. le
norme sufficienti per risolvere i problemi conseguenti alla
revoca giudiziale dell’accomandatario. Ed invero, nel
caso di pluralità di soci accomandatari, la sostituzione
dell’accomandatario revocato non sarà problema
da porsi, valendo anche in tale ipotesi, il regime dell’amministrazione
disgiuntiva per gli altri soci appartenenti alle stessa categoria.
Di contro potrà porsi il problema nel caso di unico
socio accomandatario attinto dal provvedimento di revoca,
nel qual caso, fatta definitivamente giustizia dell’opinione
dottrinale e giurisprudenziale che negava al socio accomandante
il potere di richiedere la revoca per giusta causa dell’unico
accomandatario – non avendosi in tale caso alcuna ingerenza
vietata, nella gestione della s.a.s., ma solo l’esercizio
legittimo di un potere di controllo dell’accomandante
sull’impresa sociale - potrebbe ragionevolmente sostenersi
l’applicabilità dell’art. 2323 c.c. , non
ravvisandosi in essa alcun rilievo eccezionale o di norma
speciale, ed anzi la stessa espressamente ponendo un rimedio
provvisorio endogeno alla stessa società e idoneo a
rimediare momentaneamente al mancanza dell’organo di
amministrazione sociale.
Segue
che il motivo di reclamo va rigettato, correttamente avendo
omesso il giudice reclamato ogni pronunciamento relativo alla
nomina di un amministratore giudiziario e, di contro, rilevando,
a seguito del provvedimento cautelare di revoca per giusta
causa del La Mela, la posizione gestoria dell’unico altro
socio, il quale risulta allora ex lege investito dei poteri
di gestione e amministrazione, ciò almeno fintantocchè
il dissidio tra i due unici soci risulterà avere trapassato
ogni ulteriore ragionevole limiti, tale da denunziare una
impossibilità definitiva di prosecuzione del rapporto
sociale e di conseguimento dell’oggetto sociale (art.
2272, n. 2, c.c.) e tale quindi da necessitare gli opportuni
provvedimenti di messa in liquidazione e scioglimento della
società.
2)
RECLAMO IN VIA INCIDENTALE.
Individuazione
socio amministratore.
In
primo luogo chiede la Farinato voglia il Tribunale inibire
la facoltà di amministrazione del socio La Mela, attribuendole,
quale altro socio della s.n.c., in via esclusiva il potere
gestorio.
Tale
motivo di reclamo proposto in via incidentale è infondato,
debitamente considerando che nessuna specifica pronuncia integrativa
e sostitutiva del provvedimento reclamato risulta essere necessaria
per i motivi anzi espressi dell’essere stata investita
la socia Farinato automaticamente del potere gestorio in conseguenza
della pronunzia cautelare di revoca del socio amministratore.
Sequestro
giudiziario dell’azienda.
In
secondo luogo censura il provvedimento reso in prima istanza
nella parte in cui ha rigettato, dichiarandola inammissibile,
la richiesta di sequestro giudiziario dell’azienda per
difetto di strumentalità della domanda rispetto all’azione
di merito proponenda.
A
tal riguardo ritiene il Collegio di dovere confermare senza
ulteriori precisazioni la soluzione negativa accolta dal giudice
reclamato, il quale ha richiamato la giurisprudenza consolidata
di questo Tribunale in materia, giurisprudenza peraltro assolutamente
conforme all’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale
prevalente (oltre al Tribunale Trani richiamato dal g.d.,
v. Tribunale Napoli 25.2.1994, Tribunale Piacenza 28.2.1995;
Tribunale Napoli 20.4.1994;).
Esclusione
dalla compagine sociale del socio revocato.
Infine
ripropone la Farinato la domanda di esclusione in via d’urgenza
del La Mela dalla società, rigettata dal giudice di
prime cure sotto il profilo dell’insussitenza del fumus
boni iuris.
Segnatamente
lamenta il reclamante in via incidentale che “lo stesso
provvedimento, dopo avere ritenuto i fatti accertati rilevanti
ai fini della revoca dell’amministratore, li dice non
capaci, proprio perché non sufficientemente gravi,
di motivare l’esclusione del socio dalla società.
Non si comprende tuttavia da quali norme il Tribunale abbia
tratto la convinzione che le due misure presuppongano livelli
diversi di gravità, né si comprende perché
abbia valutato i fatti così gravi da giustificare la
revoca dell’amministratore”.
Ora
ritiene il Collegio - in primo luogo - di dovere ribadire
che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale preferibile,
la violazione degli obblighi inerenti alla qualita’ di
amministratore puo’ comportare oltre alla revoca dell’amministratore
anche l’esclusione del socio soltanto allorquando le
violazioni siano cosi’ gravi da incidere anche sul rapporto
societa’ socio, non essendovi coincidenza automatica
tra le due fattispecie (Tribunale Milano 3.2.1983). Segnatamente,
richiamandosi i contributi dottrinali in materia, quanto ai
rapporti tra le fattispecie disciplinate dagli artt. 2259
e 2286 c.c. e le rispettive sfere di operatività, le
soluzioni prospettate si possono brevemente individuare nella
completa identificazione degli istituti e nella intercambiabilità
delle relative sanzioni, nella differenziazione qualitativa
della tipologia di inadempimenti se di rilievo amministrativo
o sociale, ovvero nell’affermazione dell’intersezione
delle due ipotesi in una serie di circostanze rilevanti ai
fini tanto della revoca che dell’esclusione.
All’uopo
l’impraticabilità della prima soluzione emerge
– indipendentemente dal rilievo che così ritenendosi
si finirebbe in modo irrazionale per trattare in modo arbitrariamente
identico ipotesi non omologhe - sol che si ponga attenzione
al dato sistematico desumibile dal raffronto letterale dei
due articoli richiamati, i quali nel riferirsi distintamente
alla circostanza costitutiva della giusta causa e delle gravi
inadempienze indicano una distinzione contenutistica doverosamente
orientata alla diversità ed intensità delle
sanzioni che ciascuno di essi prevede e commina, sì
da doversi concludere che per l’esistenza di una sicura
differenziazione quantitativa dell’intensità della
lesione al rapporto fiduciario che ha a verificarsi nei due
casi, richiedendo solo l’art. 2286 c.c. che l’inadempimento
determinante l’esclusione si colori dell’ulteriore
requisito della gravità.
Diversamente,
come rilevato, altra dottrina ritiene, fondandosi sulla distinzione
tra rapporto sociale e rapporto gestorio discendente dalla
preposizione institoria o di mandato, possibile distinguere
nettamente la revoca per giusta causa conseguente alle violazioni
degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato che lega
amministratore alla società d’esclusione del socio
per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal rapporto
sociale.
La soluzione non è condivisibile, e non tanto perché
s’intenda sostenere che è pur sempre la legge
che assegna al socio amministratore il potere gestorio, ma
perché, da un lato, omette di considerare come rapporto
sociale e rapporto gestorio risultano intimamente connessi
nelle società di persone - l’uno fondando e giustificando
comunque l’altro anche nel caso in cui vi sia stato conferimento
del potere di amministrazione con atto separato rispetto all’atto
costitutivo – e, dall’altro, risulta di difficile
applicabilità concreta allorquando postula la puntuale
distinzione del tipo di inadempienza posta in essere dal socio
amministratore. Proprio in caso in esame né da esemplificativamente
conferma, debitamente considerando come se, da un lato, il
tenere una contabilità in nero costituisca patente
violazione dei doveri incombenti sull’amministratore,
d’altra parte, l’appropriarsi degli utili conseguiti
da parte dello stesso amministratore non può certo
ritenersi comportamento non incidente sulla qualità
del rapporto sociale e fatto connotato da una evidente gravità
tale da consigliarne l’esclusione (v. in termini Appello
Bari 31.10.1977 e Cass. civ. 30.1.1980 n. 710).
Sembra
certamente preferibile allora ritenere che l’attuale
impianto normativa legittimi l’esclusione del socio amministratore
allorquando lo stesso abbia violato obblighi sullo stesso
incombenti nella qualità di amministratore e la violazione
abbia i connotati e le caratteristiche della gravità
tali da permettere di richiamare la previsione sulle gravi
inadempienze prevista dall’art. 2286 c.c.. In tal senso
allora il criterio discretivo relativamente alle violazioni
commesse dal socio amministraore sarebbe quello meramente
quantitativo della graduazione della sazione in ragione dell’intensità
(id est della gravità) della violazione perpetrata
(v. a tal riguardo, oltre le succitate Appello Bari 31.10.1977
e Cass. civ. 30.1.1980 n. 710, anche Cass. civ. 9.7.1977;
Cass, civ. 17.1.1956 n. 103).
Fatta
tale doverosa premessa, osserva il Collegio, come, sempre
in punto di fumus, la decisione del g.d. non sia condivisibile
nel merito della valutazione operata: ed invero, se il g.d.
ha mostrato di adeguarsi alla surriferita soluzione interpretativa
allorquando ha affermato – onde negare l’esclusione
in via d’urgenza del socio amministratore – che
“le pur riscontrate irregolarita’ non appaiono connotate
da una gravita’ tale da giustificare anche l’esclusione
del La Mela dalla compagine sociale” , lo stesso ha poi
omesso di considerare (recte, ha erroneamente valutato) che
proprio le su censurate condotte poste in essere dal socio
amministratore (e quindi a prescindere dal se vi sia o meno
stato adempimento all’obbligo di informazione sullo stesso
incombente nei confronti dell’altra socia) rivestono
certamente i connotati della gravità tali da giustificarne
l’esclusione dalla società medesima. Ed invero
non pare vi possano essere dubbi che le dette condotte rientrano
nel novero di quelle che sono direttamente in contrasto, oltre
che con i doveri dell’amministratore, con i fini ultimi
della società (scopo della società essendo proprio
la distrubizione degli utili conseguiti tra i soci in conseguenza
dello svolgimento in comune di un’attività economica:
art. 2247 c.c.), sì da integrare certamente il requisito
della grave inadempienza ai sensi dell’art. 2286 c.c.
(Cass. civ. 30.1.1980 n. 710).
Tale
conclusione non importa peraltro l’accoglimento del motivo
di reclamo e la conseguente statuizione in via d’urgenza
di esclusione del La Mela dalla società, difettando
l’ulteriore requisito del periculum in mora, ciò
per l’intuitiva considerazione che tutte le condotte
addebitate al La Mela sono state pur sempre rese possibili
grazie ai poteri di amministrazione dei quali egli era unico
titolare, sicchè la sua revoca ai sensi dell’art.
2259 c.c. elimina in nuce ogni possibilità che lo stesso
abbia per il futuro ad influire negativamente sulla vita della
società reiterando le violazioni oggi contestategli.
Sussistono
giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese.
P.
T. M.
Il
Tribunale di Catania, quarta sezione civile - in composizione
collegiale -, pronunciandosi nel reclamo principale proposto
da Pietro La Mela nei confronti di Farinato Vincenza e del
relativo reclamo incidentale (R.G. 11184\03),
1)
rigetta i reclami;
2)
compensa integralmente le spese del giudizio;
3)
manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.
Così
deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 19.12.2003.
Il
Presidente
Dott. G.B. Macrì
|