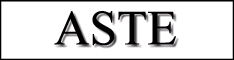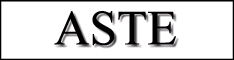|
CRISI
DELL’IMPRESA ED ALTERNATIVE AL FALLIMENTO
Professor
Michele Sandulli
Ordinario
di Diritto Commerciale presso l'Università di Roma
- III –
I.-
Innanzi tutto porgo un cordiale saluto a tutti e un vivo ringraziamento;
esprimo altresì l'apprezzamento per l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei
Lombardi, che ha organizzato questo convegno. Sono ben lieto
ed onorato di poter tenere questa relazione, che apre i lavori
di una giornata che si presenta particolarmente densa di interventi,
da cui tutti potremo trarre occasioni di riflessione. Vi prego
di consentirmi di porgere un caldo ed affettuoso saluto ai
miei ex allievi, che vedo qui numerosi e che, posso dire con
l'orgoglio del docente, dopo aver dato ottima prova da studenti
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università
di Napoli “Federico II”, non hanno tradito le aspettative,
quali professionisti.
Oggi
sono docente presso la Terza Università di Roma, ma
credo sia noto che ho sempre vissuto ad Avellino, e che in
questa Provincia ho espresso anche una significativa forma
di impegno civile e sociale. Tale complesso di circostanze
comporta che il mio intervento avrà certamente come
riferimento i profili tecnicogiuridici della crisi dell'impresa,
ma non mancherà di essere calato anche nella nostra
realtà provinciale.
Una
realtà che in larga misura si è conservata sana,
e che, quindi, come tale va preservata e difesa da ogni criminalità,
ivi compresa quella economica.
2
- Il nostro Codice Civile del 1942 ha impostato e disciplinato
il tema dell'impresa, riconoscendo alla stessa una sua centralità
nell'ambito del sistema economico produttivo. L'impresa, quindi,
è vista come strumento di raccordo tra capitale e lavoro
e, quindi, come una componente essenziale del tessuto sociale,
quale fonte e strumento di reddito per l'imprenditore e per
i lavoratori, nonchè quale strumento di produzione
nell'ambito del sistema economico nel suo complesso.
Il
Codice, impostato nella prospettiva dell'ordinamento corporativo
in un'ottica dirigistica, contiene norme che taluno ritiene
tuttora vigenti, nelle quali l'impresa diventa quasi oggetto
di organizzazione, disposizione, vigilanza da parte delle
strutture statali-amministrative: mi riferisco agli artt.
2085 e seguenti, che appunto prevedono tra l'altro che l'indirizzo
della produzione sia esercitato dallo Stato, e che vi sia
una responsabilità dell'imprenditore per il mancato
rispetto di tale indirizzo. Indubbiamente l'abrogazione dell'ordinamento
corporativo, a seguito dell'avvento della Repubblica e del
relativo sistema costituzionale, ha dato un nuovo contenuto
alla "funzione" che l'ordinamento attribuiva all'impresa;
da strumento di solidarietà corporativa a strumento
di solidarietà democratica. Cioè, l'impresa
non rileva come mera espressione della proprietà capitalistica,
bensì come entità che consente di realizzare
taluni dei principi fondamentali della Carta Costituzionale,
quali la libertà di iniziativa economica, da una parte,
e il diritto al lavoro, dall'altra.
E' evidente che alla luce di questa ottica complessa la crisi
dell'impresa non possa essere considerata come un evento "privato",
nel quale esplode il conflitto tra debitore e creditori, bensì
come un evento di rilevanza più generale, che coinvolge
una pluralità di interessi meritevoli di tutela (lavoro,
concorrenza, servizi essenziali, equilibri economici generali,
ecc.).
3
- Prima di affrontare il tema della crisi dell'impresa, ritengo
sia essenziale tenere presente una distinzione: impresa vera
e impresa non vera, impresa produttiva e impresa sanguisuga.
Al fine di evitare di considerare unitariamente fenomeni tutt’affatto
diversi, ritengo sia indispensabile questa riflessione preliminare.
Proprio
nella nostra provincia, e massimamente nella c.d. zona del
cratere del sisma del 1980, abbiamo avuto degli esempi di
imprese “fantasma”, la cui presenza sul territorio
era essenzialmente collegata alla elargizione dei benefici
del dopo terremoto che, come è noto, hanno comportato
finanziamento a fondo perduto per un’alta percentuale
delle realizzazioni che i nuovi insediamenti industriali operavano.
Abbiamo visto numerose imprese entrare in crisi e fallire,
talvolta prima del completamento degli opifici, talvolta poco
dopo l’avvio della produzione (peraltro priva di quei
requisiti organizzativi e strutturali che l’erogazione
del finanziamento supponeva, con conseguente decadenza dagli
“aiuti”).
Altra
tipologia è quella delle imprese che si organizzano
per raccogliere risparmio, cavarlo dalla tasca di tanta gente
semplice, allettata dalla promessa di miracolosi interessi,
e poi dissiparli o distrarli per iniziative “personali”
del tutto estranee alla finalità dell'impresa finanziaria.
Anche in quest’area geografica, di recente, sono state
vissute amare esperienze di tal genere; così come del
resto qualcosa di molto simile (anche se con valori più
consistenti) si è avuto a Napoli.
Ancora,
a questa categoria d'impresa “negativa” appartiene
l'impresa camorristica o mafiosa, destinata spesso ad investimenti,
la quale opera in funzione del riciclaggio di danaro sporco
da attuare in un arco di tempo limitato, ovvero con finalità
di preordinato inadempimento alle obbligazioni (tipica l’apertura
di supermercati, l’acquisto a credito di merci e la successiva
“scomparsa” degli imprenditori).
Per
tutte queste tipologie di imprese la crisi si concretizza
rapidamente e si manifesta non appena “l’operazione”
ha dato i propri preordinati “frutti”. In questi
casi, ovviamente, la crisi è assolutamente irreversibile,
perché si tratta di imprese destinate ad entrare in
crisi proprio per disegno dell’imprenditore, rispetto
alle quali, quindi non si può neppure ipotizzare un
risanamento, o un salvataggio. Per queste imprese, sovente
chiaramente identificabili ab initio la vera esigenza è
quella di creare un cordone sanitario preventivo, che, abbia
la capacità, la forza e l’idoneità di evitare
che si costituiscano; ovvero, che, una volta costituite ed
entrate nel mercato, perseguano fino in fondo il loro “criminale”
disegno. A tal proposito deve essere certamente rivalutata
quell’attività che spesso è considerata
di routine, quale quella relativa al giudizio di omologazione
dei contratti di società da parte del Tribunale, o
quella del Giudice del Registro delle imprese in relazione
al trasferimento nelle nostre aree della sede dell’impresa;
così come quella attività di rilevazione di
fenomeni anomali (per natura dell'attività, provenienza
dei soggetti, dimensione del capitale) da parte degli organi
di polizia tributaria e non.
Una
particolare attenzione nella fase dell’insediamento certamente
almeno scoraggerebbe certe iniziative o le terrebbe lontane
da una determinata area geografica. Ovviamente più
complicato è il discorso per le imprese, costituite
altrove, che si trasferiscono nel territorio “da conquistare”.
In tal caso diventa importante l’attenzione per certi
fenomeni economici da parte delle forze di polizia, le quali
dovrebbero essere sensibilizzate ad operare verifiche e controlli
in situazioni che si presentano non omogenee all’ambiente
nelle quali trovano estrinsecazione (così, per esempio,
l’operatività di società finanziarie o
di altri enti che più o meno surrettiziamente raccolgano
risparmio e/o erogano prestiti o finanziamento dovrebbe indurre
a tempestive verifiche).
Quindi,
per queste imprese vi sono dei problemi particolari, che nascono
dalla loro pericolosità. Problemi specifici, che meritano
un convegno a parte, dove sarebbe interessante sentire anche
la voce delle Autorità di pubblica sicurezza, di chi
deve avviare l’azione penale, dell’economista. Confido
che chi ha avuto la sensibilità, la dedizione e la
pazienza di organizzare questo incontro, se ne possa fare
carico.
4
- Veniamo ora alla figura che in questa sede interessa, all’impresa
produttiva, l’impresa creata per la produzione di beni
o di servizi, la quale può entrare in crisi per una
serie di ragioni (lo accennava già prima il dr. Mordente).
Talvolta
la crisi si risolve all’interno dell’impresa stessa;
ciò accade quando gli elementi di rottura non sono
particolarmente gravi, ovvero investono l’impresa per
un breve periodo, ovvero perché l’imprenditore
tempestivamente ha la capacità o la prontezza di adottare
le opportune misure di recupero. In mancanza, la crisi si
risolverà in uno stato di insolvenza, eventualmente
all’inizio non manifestato, successivamente emergente
da episodi isolati, e infine platealmente conclamato. La crisi
può dipendere da fattori endogeni o da fattori esogeni;
spesso le due cause si sommano ed assumono il potere di un
moltiplicatore.
Con
riferimento alle vicende interne all’impresa, ritengo
che la prima causa di crisi vada ritrovata nei problemi finanziari.
Il
nostro sistema giuridico non richiede alcun livello di capitalizzazione
per l’imprenditore individuale e per le società
di persone; una capitalizzazione irrisoria per le società
cooperative; una capitalizzazione oggettivamente “minima”
per le società per azioni, a responsabilità
limitata, in accomandita per azioni. Peraltro, un dato comune
per tutti è l’assenza di un rapporto legale (di
tipo normativo o di tipo amministrativo) tra capitale e/o
patrimonio e giro di affari (fanno eccezione al riguardo essenzialmente
solo le società che operano nel settore finanziario,
quali banche e società assicurative). Può dirsi,
insomma, che un dato generalizzato, al riguardo, è
la sottocapitalizzazione. Da ciò discende, che quando
la effettiva capacità produttiva non riesce a coprire,
oltre i costi di produzione, gli elevati costi finanziari,
l’impresa si viene a trovare rapidamente in difficoltà.
Tale
situazione incide sulla crisi, aggravandola per quanto attiene
i suoi effetti per i creditori, anche sotto altro angolo visuale.
E ciò a cagione del “normale” comportamento
del ceto bancario.
Infatti,
in presenza di questo insufficiente livello di capitalizzazione,
mentre il fornitore fa credito essenzialmente facendo affidamento
sul patrimonio dell’imprenditore debitore, ma ancor più
sulla sua capacità imprenditoriale e correttezza commerciale,
la banca per lo più fa credito fondando sul patrimonio
di un terzo fideiussore o di un terzo datore di ipoteca; per
cui, l’imprenditore di fatto riceve credito (e, quindi,
assume debiti) per un valore eccedente il valore del suo patrimonio.
Questo comporta che necessariamente l’imprenditore avrà
assunto impegni superiori alle proprie forze, rispetto ai
quali il ceto bancario è protetto, in quanto gode oltre
che della garanzia patrimoniale del debitore, della garanzia
di un terzo. Gli altri creditori, invece, vedono concorrere
sull’unico patrimonio responsabile anche la banca, che
comunque come dicevo, per lo più, gode anche di garanzie
estranee.
Altro
diffuso elemento di crisi è costituito dalla incapacità
dell’imprenditore di organizzare, in forme efficienti
la propria azienda, sì da produrre ad un giusto livello
di economicità.
Massimamente
con riferimento alla piccola impresa, abbiamo talvolta bravi
operai o bravi artigiani, i quali diventano “imprenditori”,
pur essendo privi di qualsiasi nozione (o qualsivoglia istruzione)
per potere applicare corretti principi o regole d’impresa.
In questi casi il mancato riferimento ad un valido esperto
aziendalista diventa essenziale per l’impresa. E ciò,
sia per quanto attiene l’organizzazione dell'azienda
sia, e massimamente, per quanto attiene la struttura finanziaria.
Al
riguardo va anche ricordato il fenomeno della sottrazione
dei fondi d’impresa. Spesso, infatti, l’imprenditore
pensa che “il ricavo” sia “l’utile”.
Quanti imprenditori di piccolo-media dimensione diventano
insolventi perché con i ricavi d’impresa si costruiscono
una bella villa!
Temo
in parecchi; proprio perché non c’è l’educazione
a comprendere quale debba essere la destinazione dei ricavi;
e, quindi, quale debba essere il rapporto tra il prelievo
che fa l’imprenditore e la parte che, invece, egli deve
necessariamente lasciare nell’impresa.
Con
riferimento ai profili esogeni, può ricordarsi che
la crisi dell’impresa può derivare da, una crisi
generale del sistema economico, da una crisi sviluppatasi
in una determinata area geografica, da una crisi di settore,
cioè del settore specifico, nel quale la stessa opera,
oppure, e forse è questa la causa più frequente,
da limiti o incapacità propria dell’imprenditore
ad adattarsi ai fattori ambientali esterni. Ancora, può
accadere che l’imprenditore perda canali o fonti di lavoro
che in precedenza riusciva ad utilizzare (forse si può
indagare su come li avesse acquisiti; ma questo potrebbe essere
un sotto-problema); oppure a causa della prima ricordata carenza
di capitalizzazione iniziale dell’impresa stessa, e di
una correlata “incapacità” di poter far ricorso
al credito.
5
- Tali elementi sono tra quelli che in via autonoma o in connessione
tra loro in tempi medio-brevi riducono l’impresa in difficoltà.
In teoria, secondo una certa dottrina, in un mercato a concorrenza
perfetta l’insolvenza dell’impresa non costituisce
un grave danno, in quanto all’impresa insolvente si sostituirà
l’impresa sana; quindi, non si produce alcun pregiudizio
al sistema economico globale che conserva la propria potenzialità
produttiva, né alle energie lavorative, che si trasferiranno
nella impresa che, nel sistema, sostituirà quella decotta.
Nella
realtà, a parte che il sistema di concorrenza perfetta
non esiste, noi sappiamo che, proprio negli ambienti economici
più deboli, in fondo, l’insolvenza di una impresa
è una perdita secca per la collettività, non
recuperabile. E’ una distruzione di ricchezza, in quanto
gli strumenti organizzati, le attrezzature, i macchinari,
alla fine, non saranno più utilizzati come potenzialmente
avrebbero potuto esserlo; allo stesso tempo, la mano d’opera
non viene subito riassorbita in iniziative alternative. Tutto
questo comporta che, oltre la mancata utilizzazione di professionalità,
c’è un massiccio ricorso al sostegno pubblico,
che, come accennavo, proprio per la impossibilità del
mercato di dare accesso a collocazioni alternative nel mondo
dei lavoro, è destinato ad essere utilizzato per numerosi
anni, anche attraverso “l’invenzione” di sempre
nuovi strumenti. E’ noto che nelle zone più povere
si ha un ricorso ai c.d. ammortizzatori sociali, sovente ben
oltre il termine massimo di diciotto mesi previsti dall'art.
3 L. 223/91.
6
- Molti, quando c’è insolvenza, imputano al fallimento
le ragioni della dissoluzione dell’impresa e del mancato
o lento soddisfacimento dei creditori. Si afferma spesso che
la disciplina del fallimento sia carente, e perciò
non si risolvono in modo soddisfacente i problemi provocati
dall’insolvenza. Ma dico: se c’è crisi irreversibile
nessuna procedura concorsuale può provocare un’inversione
di rotta; la migliore delle leggi fallimentari non può
capovolgere una situazione ormai decotta. Indubbiamente si
può pensare ad una procedura fallimentare che concorra
in modo da raccogliere ciò che di buono ci può
essere ancora nell’impresa insolvente, e consentirne
il riutilizzo.
Da
anni si discute di riforma del diritto fallimentare; ancora
oggi c’è una Commissione ministeriale che ha allo
studio questa riforma (di cui, tra l’altro, fa parte
il Dott. Serao), anche se è una Commissione che è
rimasta sostanzialmente congelata, a seguito delle modificazioni
avutesi al vertice del Ministero di Grazia e Giustizia. Però,
se c’è un problema di riforma della Legge Fallimentare,
che indubbiamente può essere in qualche modo migliorata,
la possibilità di una soddisfacente soluzione, per
fare in modo che le crisi non si risolvano in buche incolmabili,
va ricercata nel sistema giuridico nel suo complesso, con
riferimento anche ad altri ben più ampi profili.
Innanzitutto,
penso a quel profilo a cui poco fa accennavo del vincolo di
capitalizzazione dell’impresa; si impone innanzitutto
la necessità di rendere obbligatorio in qualche modo,
un rapporto minimo tra il capitale investito, o comunque,
il patrimonio netto dell’impresa, e il giro d’affari.
Come dicevo, qualche cosa di simile si ha nelle imprese che
sono sottoposte a vigilanza ministeriale, come per es. le
imprese assicurative, dove c’è questo rapporto
e, dove, nel momento in cui questo rapporto scende al di sotto
di un certo minimo, scattano limiti (amministrativi) alla
operatività dell'impresa. Si potrebbe eccepire che,
se si generalizzasse tale sistema, avremmo un sistema imprenditoriale
ingessato da vincoli amministrativi e sottoposto al dirigismo
statale. Io penso che certe forme di rapporto tra patrimonio
netto e giro d’affari potrebbero avvenire anche senza
un vincolo di carattere dirigistico, ma, appunto, in quanto
affidate alla responsabilità del tecnico aziendale
che assiste l’imprenditore.
Anzi,
potrebbe, addirittura costituire il vincolo ad un certo parametro
anche una sorta di “caratteristica di qualità”
dell’impresa, che possa essere utilizzata per meglio
presentarsi sul mercato; e che potrebbe anche diventare motivo
per conseguire condizioni più favorevoli (soprattutto)
sul mercato del credito.
Poi,
vi è un altro fondamentale profilo, cioè quello
relativo al processo civile; se le procedure fallimentari
durano otto, dieci, dodici, o anche venti anni e oltre, dove
questo accade, e credo che accada un pò dappertutto,
lo si deve, io penso, soprattutto alla lentezza del processo
civile. Posso citare una mia esperienza diretta di curatore
di un fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli nel 1983
dove, ad oggi, taluni giudizi, aventi ad oggetto azioni revocatorie
fallimentari, non sono ancora giunti ad una sentenza di primo
grado (benchè iniziati tempestivamente). Pensate, poi
ci potrà essere il giudizio di appello e, quindi, il
ricorso per Cassazione, con eventuale giudizio di rinvio.
Alla stessa stregua, sono stato costretto, sempre come curatore,
a proporre ricorso in sede tributaria avverso il diniego di
un rimborso di credito per IVA vantato dalla società
poi fallita; sono passati nove anni per giungere alla decisione
della Commissione Centrale che, confermando le decisioni di
primo e di secondo grado, ha riconosciuto il credito del fallimento;
successivamente ho impiegato due anni per ottenere dal Ministero
delle Finanze il rimborso del capitale e circa un altro anno
per ottenere il rimborso degli interessi. Quindi, pensare
di riformare il diritto fallimentare, mettendo mano solo alla
legge fallimentare, secondo me, è solo una perdita
di tempo, o quanto meno un progetto illusorio. Cioè,
è necessario, perché si possa sperare in un
qualche risultato proficuo, che vi sia una connessione tra
tutti quelli che sono i fenomeni che trasversalmente intervengono
nel momento della crisi e nella procedura concorsuale che
ne consegue.
7
- Ma perché dal fallimento deriva un grave pregiudizio
per l’economia in generale e per i creditori in particolare?
Perché in effetti, il fallimento arriva quando ormai
la situazione patrimoniale è irreparabilmente compromessa.
Parlando in termini generali, e con salvezza delle eccezioni
che la realtà offre, in linea di massima, ci si viene
a trovare di fronte ad uno sbilancio tra attivo e passivo.
Solo in casi molto marginali il Fallimento investe un patrimonio
immobilizzato, ma ictu oculi attivo. Quindi, il pregiudizio
per i creditori deriva o da questa prevalenza del passivo
sull’attivo, e/o dal ritardo con il quale il ricavato
dell'eventuale attivo sufficiente per soddisfare tutti i creditori
viene distribuito, e per di più senza gli interessi
per creditori chirografari. In linea di massima, poi, è
da ricordare che l'attivo, una volta che da “attivo dell'impresa”
diventa “attivo del fallimento” subisce una falcidia
notevolissima del proprio valore nel momento in cui si attua
la liquidazione.
Invero,
l'attivo perde larga parte del proprio valore, innanzitutto,
perché, cessando l'attività di impresa, si perde
il valore di avviamento, per i lunghi tempi di fermo dei beni
(si ricordi che non si può procedere alla vendita,
se non dopo che è stato reso esecutivo lo stato passivo:
art. 104 I. fall.); inoltre, per le difficoltà, cui
facevo cenno, di dismissione proprie delle vendite forzate.
In genere, gli acquisti in tale sede avvengono a prezzi molto
bassi, solo se si tratta di un bene che abbia un valore “speciale”
ed oggettivo, e l'ufficio fallimentare si mostri ferreo, si
può recuperare qualche valore accettabile.
8
- Allora, la verità è che solo una effettiva
prevenzione può consentire che le crisi abbiano una
qualche soluzione positiva. Una prevenzione che, in qualche
modo, consenta gli interventi più adeguati, sia in
una eventuale fase stragiudiziale, sia per consentire il ricorso
adeguato alle procedure alternative al fallimento (e non un
ricorso disperato, residuale, cioè un ricorso quando
tali procedure oggettivamente non hanno più alcun senso)
sia per arrivare ad una tempestiva dichiarazione di fallimento.
Certamente, in questo, i dottori commercialisti, che svolgono
attività di assistenza e di consulenza alle imprese,
hanno una specifica funzione, aggiungerei una funzione doverosa.
Esistono certamente gli strumenti tecnico-giuridici perché
il professionista possa svolgere in maniera efficace questa
funzione: tra gli altri, non ultimo, la nuova struttura del
bilancio, dove si evidenziano in maniera più analitica
i profili patrimoniali e finanziari, con quella distinzione
relativa ai termini di scadenza per il pagamento dei debiti
ed ai termini di scadenza per l'incasso dei crediti che influenza
la prognosi anche su quella che può essere la situazione
finanziaria.
Ma dobbiamo chiederci se il commercialista, il tecnico che
assiste l'impresa, è messo nelle condizioni di svolgere
a pieno le proprie funzioni. Purtroppo, nelle piccole imprese
l'assistenza del tecnico, del professionista, sovente è
molto limitata ma non perché questo si rifiuti di dare
assistenza, bensì perché l'imprenditore non
solo non la la vuole; egli si limita a consegnare un pacchetto
di fatture a fine mese, ed il commercialista le annoterà
sui libri contabili, per poi alla fine predisporre il bilancio
“fiscale".
E,
per esperienza, mi consta che pure quando il professionista
ha tentato di incidere sull'orientamento che assumeva l'andamento
dell'impresa, non è stato ascoltato e, spesso, è
stato finanche sostituito. Quindi, dico che il punto di partenza,
e non lo dico perché siamo in un convegno organizzato
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, stia proprio innanzitutto
in questa necessità di educazione dell'imprenditore,
e dell'imprenditore meridionale in particolare, affinchè
comprenda l'essenzialità dell'intervento del professionista;
di un professionista preparato ed onesto, il quale non abbia
la funzione di assecondare il titolare dell'impresa, bensì
quella di vagliare con spirito critico le sue iniziative,
e avanzare le proposte migliorative dell’organizzazione
e di ogni altro aspetto aziendale rilevante. Spesso, invece,
l’imprenditore nasconde la vera situazione al professionista;
fin quando, poi, non è arrivato allo stadio terminale.
Devo
aggiungere, peraltro, che questa difficoltà di operare
dei professionista si ritrova sovente anche nella grande impresa,
dove prevale il potere del management, che ha obiettivi di
bilancio, obiettivi di programmazione della propria attività,
obiettivi di gruppo, aspetto ai quali il professionista viene
talvolta messo da parte, o comunque non ascoltato.
Ritengo,
infine, che certamente il professionista non compia opera
meritoria (e giuridicamente e deontologicamente corretta)
quando, all'opposto, diventa egli stesso “ingegnere”
di costruzioni di pura sorte o addirittura in frode ai creditori.
9
- Se manca l'iniziativa dell'imprenditore, non vi è
possibilità di intervenire dall'estemo sulle difficoltà
dell'impresa. Se la difficoltà, secondo il nostro ordinamento,
non si risolve in stato di insolvenza, i terzi non possono
chiedere il ricorso ad una procedura concorsuale.
Quindi,
si deve attendere, nonostante sia emersa tale difficoltà
che si arrivi allo stato perché si possa intervenire
su iniziativa dei creditori; anzi, che si manifesti lo stato
di insolvenza. E questo si spiega; intervenire con una procedura
significa limitare l'iniziativa econornica privata, significa
interrompere l’esercizio dell'attività economica
libera, ed imporre la sostituzione dell'imprenditore con un
organo pubblico. Allora, se questo deve avvenire, puo avvenire
solo quando ricorrono certe condizioni di irreversibilità,
che giustificano tale forma di esclusione del titolare del
patrimonio, dalla gestione e dal potere di disporre.
Quindi,
il discorso ritorna necessariamente sulla prevenzione, una
prevenzione che, al momento, è affidata solo all'imprenditore.
Quando, negli anni '70 il nostro sistema economico si venne
a trovare in una fase notevolmente critica, vi fu un ricorso
anomalo alle procedure concorsuali c.d. minori (concordato
preventivo e amministrazione controllata) e al tempo stesso
una modificazione dell'art. 187 I. fall., in tema di amministrazione
controllata; con tale modifica, furono introdotte, tra i requisiti
per l'ammissione a tale procedura, anche “le comprovate
possibilità di risanare l'impresa”. Si disse all'epoca
che, in fondo, queste procedure alternative al fallimento
non tutelavano più soltanto l'imprenditore onesto ma
sfortunato, bensì avevano anche la funzione di tutelare
la sopravvivenza dell'impresa, attraverso la conservazione
delle strutture aziendali. Ma, nonostante tale orientamento,
su cui non sono sicuro di poter convenire, non si riuscì
a superare il dato normativo secondo il quale solo l'iniziativa
dell'imprenditore consentiva il ricorso all'amministrazione
controllata; in mancanza, non c'era possibilità di
surroga.
Ricordo
che in quegli anni ci fu anche un progetto redatto con molta
cura da tre dottori commercialisti, Chiaraviglio, Gerini e
Serveglini, i quali proponevano proprio la possibilità
di un intervento preventivo sull'impresa in crisi ad iniziativa
dei creditori, che, appunto, consentiva al Tribunale di poter
“entrare” nell'impresa prima che si fosse verificata
l'insolvenza, e di concordare con l'imprenditore le possibilità
di soluzioni che potevano essere individuate. Ma questo progetto
non ebbe poi sbocco; così come i progetti di riforma
della Legge Fallimentare, che in qualche modo raccoglievano
tale proposta, sono rimasti sostanzialmente fermi.
A
questo punto una qualche strada bisogna pure indicarla. Il
punto di partenza deve essere innanzitutto questa capacità
di analisi interna da parte dell'imprenditore, rispetto alla
quale giungere ad una valutazione globale della situazione.
Sulla base di tali valutazioni tempestive si dovrebbe scegliere
qual è la strada da percorrere per giungere ad un recupero
produttivo o almeno ad una “sistemazione” delle
posizioni debitorie. Verificare se sussistono le condizioni
per un concordato stragiudiziale con tutti i creditori, con
la consapevolezza che se - una volta stipulato - lo stesso
non venga completamente adempiuto, si avrà necessariamente
il fallimento e ci si esporrà ad una serie di azioni
revocatorie.
Altra
ipotesi è la possibilità di alienazione di un
ramo dell'azienda; ma se questo avviene nel momento in cui
si è già manifestato lo stato di insolvenza,
difficilmente si potrà concretizzare, perché
anche questo diventerà un atto revocabile nel caso
di fallimento.
Quindi, perché l'imprenditore possa avere una piena
autonomia nel potere di disporre di parte dei propri beni
o nell'organizzare in qualche modo degli accordi transattivi,
è necessario intervenire prima che si manifesti lo
stato di insolvenza; ma si badi, non perché l'imprenditore
sia riuscito ad occultarlo, ma perché non si è
ancora concretizzato all'interno dell'impresa. Quindi, è
in questa fase preliminare che si possono fare tali opzioni.
So
che tutto ciò è difficile; l'imprenditore, per
carattere, è ottimista: spesso rifiuta di leggere la
realtà; è geloso della sua autonomia: in fondo
l'imprenditore ha una sua Struttura mentale particolare, che
è difficile modificare o indirizzare. E' un dato caratteriale
che è alla base della stessa attività di impresa;
ma è su questo dato caeatteriale che il “consulente”
deve avere la possibilità di incidere.
Ciò
perché queste operazioni possono essere compiute solo
prima che la difficoltà all'interno dell'impresa sia
irreversibile, e comunque prima che si sia manifestato lo
stato di difficoltà di adempiere o uno stato di insolvenza.
Infatti, dopo sarà difficile dar corso ad operazioni
di questo tipo, perché i terzi sono consapevoli di
poter subire l'azione revocatoria; allora, o non si trova
il contraente o lo si trova, ma “a caro prezzo”
per l'imprenditore; nel senso che il terzo sarà disposto
a contrattare solo se copre il rischio della revocatoria.
Allora, in tale ambiente, queste operazioni o non porteranno
mai ad un risultato utile o se pure porteranno a un risultato
utile avranno pregiudicato la potenzialità economica
dell'imprenditore, facendogli pagare il costo della crisi
non quanto vale, ma almeno il doppio.
10
- Ci potrebbe essere anche un'altra possibilità alla
quale però certamente voi guarderete un poco con sospetto.
Comunque come ipotesi di lavoro si può proporre, perché,
poi, certe situazioni una volta verificatesi sono viste in
modo diverso. Il nostro ordinamento (art. 5 I. fall.) innovando
rispetto al codice di commercio che faceva riferimento come
presupposto oggettivo del fallimento allo stato di cessazione
dei pagamenti, ha identificato una situazione, direi un po'
nebulosa, come lo stato di insolvenza; cioè, una situazione
oggettiva che non ha dei contorni precisamente definiti. Per
cui, in fondo, c'è un'area di interpretazione di questo
concetto di stato di insolvenza, che può partire da
una prognosi di incapacità di adempiere alle proprie
obbligazioni anche con riferimento al futuro, per arrivare
fino al momento della incapacità attuale di adempiere.
Quindi,
se si volesse interpretare questa situazione di insolvenza
in maniera in qualche modo prognostica, si potrebbe anche
arrivare ad un fallimento quando la situazione matrimoniale
non è ancora pregiudicata. E badate, questo non significa
distruggere l'impresa e sottrarla definitivamente all'imprenditore.
Ciò in quanto un fallimento, ben condotto, di un'impresa
che non è decotta, può diventare un momento
attraverso il quale, addirittura l'imprenditore, se l'impresa
aveva ancora un suo pezzo di utilità, potrebbe riprendere
la propria attività o attraverso un concordato o con
il residuo attivo della liquidazione fallimentare. E' chiaro
che il fallimento diventa un momento distruttivo irreversibile,
un pregiudizio senza speranza sia per l'imprenditore che per
i crediton, quando ci si arriva con una situazione assolutamente
irrecuperabile; quando ci si arriva dopo aver compiuto atti
di astrazione o di distruzione, che saranno sanzionati penalmente.
Bisogna
ricordare, andando oltre la sensibilità comune che
vede nel fallimento una situazione infamante, che questa procedura
oggi - pur comportando talune limitazioni - ha tale risvolto
solo come eventuale. Basti pensare che con il pagamento integrale
dei creditori e delle spese della procedura si può
ottenere immediatamente la riabilitazione (art. 143 n. 1 I.
fall.) e quindi la cancellazione dal registro dei falliti
(art. 50 I. fall.). E' caduto il carattere infamante 2 che
caratterizzava tale procedura nelle legislazioni anteriori;
la sanzione penale è prevista solo nei casi in cui
sono stati tenuti particolari comportamenti pregiudizievoli
per i creditori o che offendono la fede pubblica.
Al
tempo stesso il fallimento si può tradurre in uno strumento
di prosecuzione dell'attività d'impresa, attraverso
l'esercizio provvisorio (art. 90 I. fall.) che, quindi, può
consentire una realizzazione globale dell'azienda, la quale
così non perde neanche il valore di avviamento. Insomma,
è anche attraverso questa ottica che si può
guardare al fallimento.
Si
può quindi, se pure con grande approssimazione, concludere
nel senso che la irreversibilità della crisi, lo scarso
soddisfacimento dei creditori, la distruzione di ricchezza
non sono l'effetto delle procedure concorsuali o un carattere
naturale delle stesse. Cioè, in larga misura, non è
un problema di procedure concorsuali: il problema è
di come ci si arriva.
|